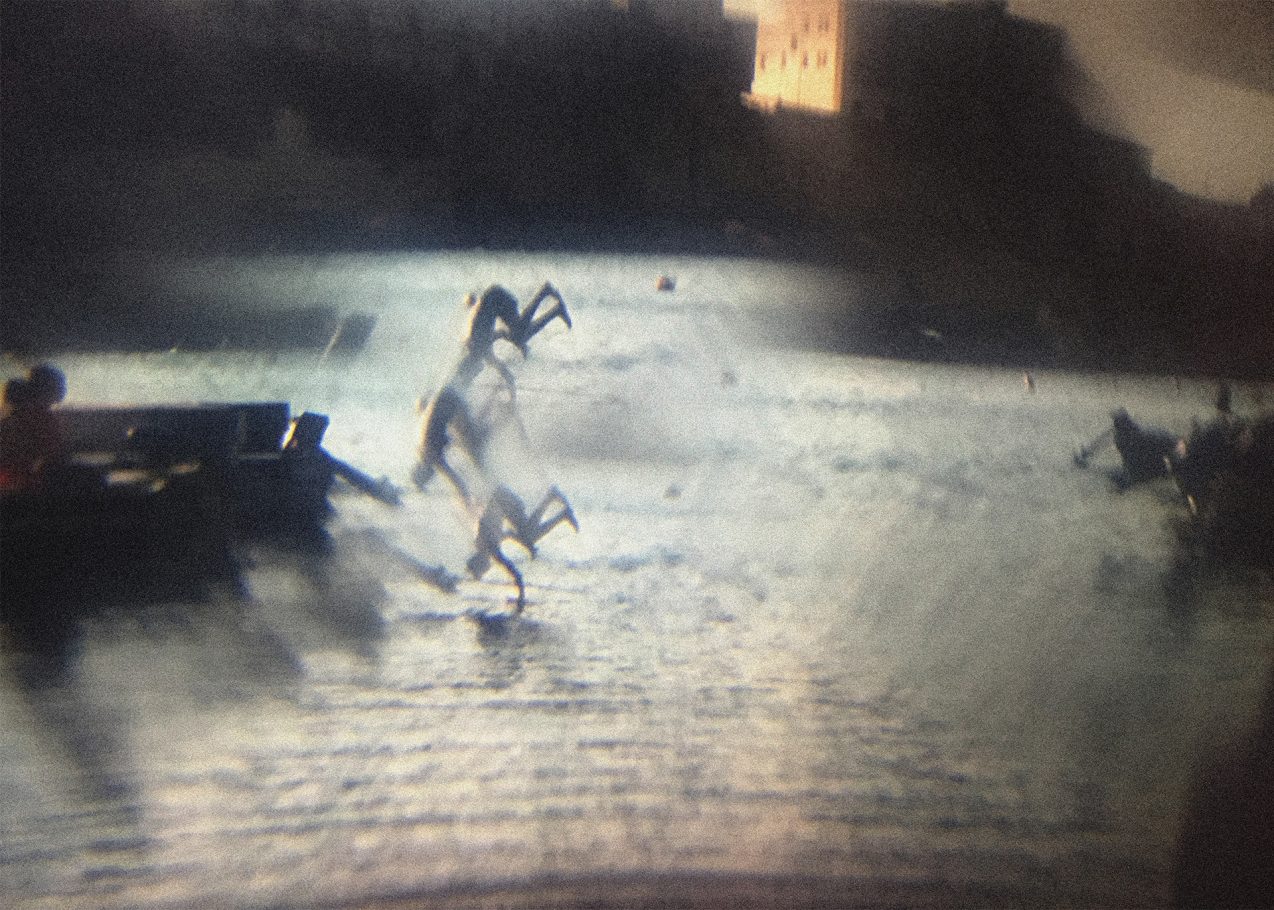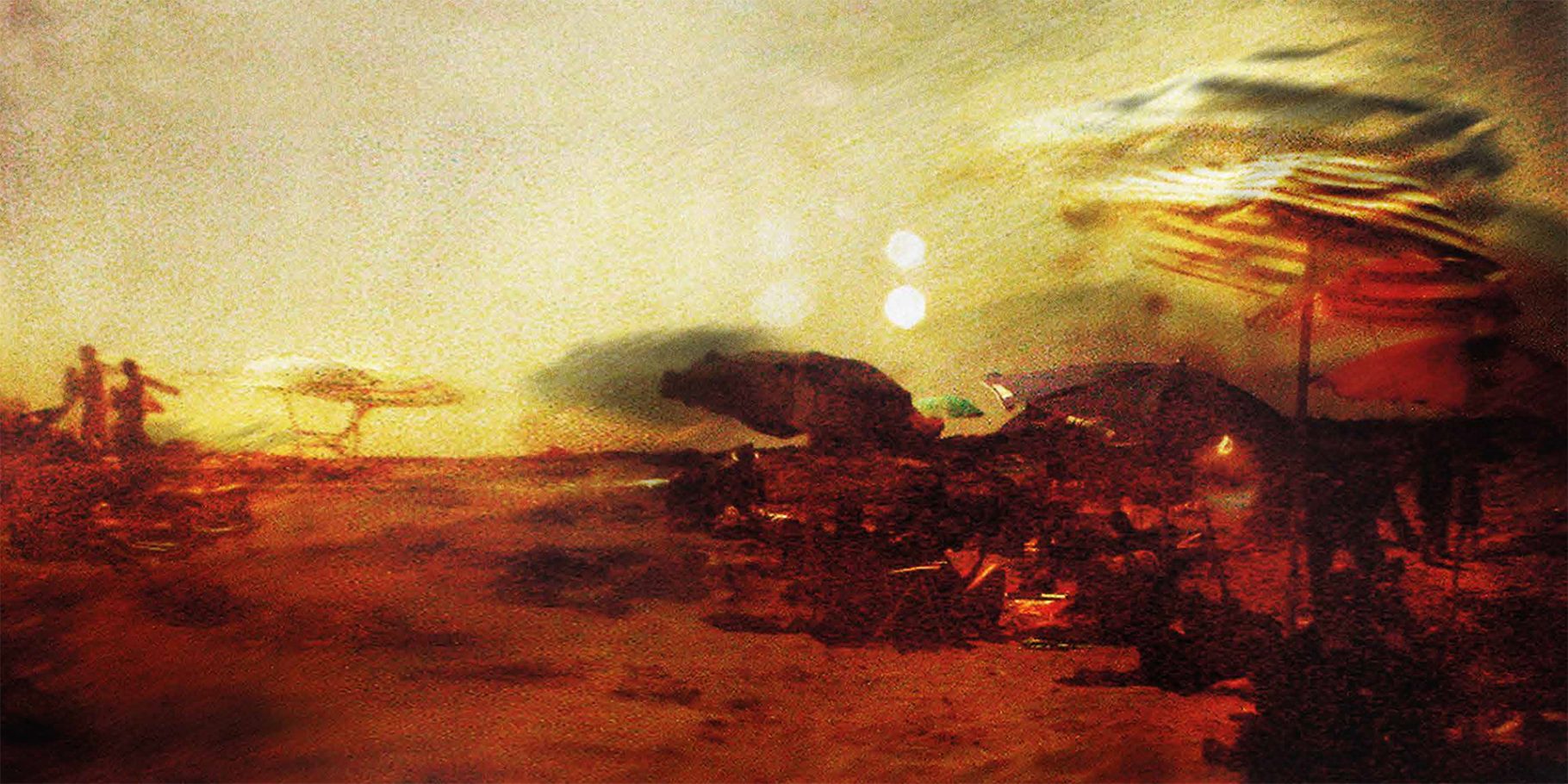Solo Exhibition @ UniCredit Pavilion
Milano, Aprile - Maggio 2016
Testo critico di Pasquale Barbella
Le immagini sono come il denaro: l’inflazione le spoglia di valore, di potere e di senso. La tecnologia digitale, rovesciando a getto continuo miliardi di figure su una quantità di supporti elettronici fissi e portatili, deposita – persino sulle opere d’autore – un’ombra di depressione analoga, per certi aspetti, alle conseguenze dei black days di Wall Street. A risentire maggiormente di questo collasso è l’iconografia dei sogni, e il sogno più condiviso dall’umanità è la vacanza, simbolo di fulgida evasione e superiore benessere. La rete trabocca di cartoline illustrate, un genere che ebbe larga condivisione nell’era della carta, ma che non ha più né la funzione sociale né l’innocente charme di quei tempi, quando spedirsele a vicenda era la prova tangibile di una prossimità sentimentale trasmessa da distanze baciate dalla spensieratezza. La proliferazione di inquadrature turistiche ha perso la capacità di stupire, adescare e sedurre, proponendosi come ridondante vetrina commerciale di alberghi, villaggi e destinazioni che sembrano uguali. A queste banconote fuori corso gli utenti rispondono con una produzione personale altrettanto implacabile, impallando e declassando paesaggi e monumenti per farne sfondo di selfie usa-e-getta.
Al progressivo svuotamento di significati che la minaccia, la fotografia reagisce con un’arma talvolta infallibile: la provocazione. I provocatori più efficaci sono i fotoreporter e gli artisti. Ai primi è il contesto storico, con i suoi abusi e i suoi disastri, a fornire la materia prima dello choc. Agli altri è la riflessione creativa, la personale visione del mondo, la volontà di rimettere continuamente in gioco le proprie inclinazioni estetiche per caricarle di nuova dinamite. È questo il caso di Federico Garibaldi, fotografo che alla descrizione sfacciata preferisce i sottotesti. Non solo quando va a caccia di prede armato di Canon, Hasselblad o i-Phone, ma anche quando si esprime a parole. Il titolo della sua mostra all’UniCredit Pavilion di Milano, blueShores, denuncia fin dall’ironia del titolo l’ambiguità dei contenuti. Rive blu, ma quel blu è anche – in inglese – sinonimo di tristezza, amarezza, malinconia.
La spiaggia mediterranea ha assunto, dagli anni sessanta del secolo scorso, una polivalenza semantica nella quale si concentrano tutti i cliché geografici e culturali dei paesi che vi si affacciano – l’estate al mare, le chiappe chiare, gli ombrelloni, l’abbronzatura da esibire come una conquista a fine vacanza e fine illusione. La storia e la geopolitica si sono incaricate di minare la solarità incandescente di quel mito, fino a stravolgerne – nell’immaginario comune – il carattere di sublime attrazione. Violata da popoli in fuga, l’idea assoluta (e assolata) che avevamo della Spiaggia entra in conflitto con sé stessa, sprigionando dissonanze e turbamenti che credevamo estranei alla quieta adorazione delle sabbie e dell’azzurro. Alle nostre piccole fughe dallo stress quotidiano, provvisorie e ridenti, si sovrappongono fughe di segno diverso, il cui “sapore di sale” non viene dal jukebox o dagli auricolari ma da roventi grovigli di speranza e tragedia.
Garibaldi non è così ingenuo, o così moralista, da sventolarci sotto il naso l’evidenza di quella contraddizione, né si sogna di tradurla in monito didascalico e feroce. Si limita, almeno in apparenza, a rovesciare – intorbidandola – l’illusione della Spiaggia come centro di delizie paradisiache e ferragostane. Il suo blu non è dipinto di blu ma dipinto di blues. I suoi colori si spengono come lampade fulminate, o si sciolgono per desaturazione nell’acido di nebbie dolenti. Le forme perdono la sicurezza confortante dei contorni nettamente definiti, contorcendosi in un’overdose di sovrapposizioni, sopraffazioni, sovvertimenti. Il sole è spodestato da tempeste cromatiche da maltempo nordico. Le sdraio giacciono vuote e abbandonate. L’estate che si credeva o si sperava eterna e trionfante soccombe alla quinta stagione, la più severa, quella in cui si addensano gli iceberg dell’anima. La festa è finita? Sì e no: Garibaldi lascia a ciascuno di noi libertà di risposta. Ma c’è poco da esultare. Sotto i suggestivi riflessi di onde al tramonto si percepisce il languido glamour d’una bionda annegata. Come detriti di pallida carne, visti rasoterra dal mare, i bagnanti ne costituiscono uno sfondo accessorio e sbiadito. A volte si ergono, sul lungomare, edifici permalosi e notturni, popolati dai molti fantasmi dell’epoca nostra. La notte incombe sul giorno anche quando s’indovina, fuori campo, la presenza di un sole offeso, umiliato, in esilio.
Ciascuna delle immagini in mostra ha segreti da narrare, doppiezze da esibire. Opere aperte nel senso più letterale, allusive, estreme come macchie di Rorschach in libera uscita. Agitate da un impetuoso, beffardo, destabilizzante vento di poesia.
On the beach
di Pietro Geranzani
Nel 1959 è uscito nel sale un film di Stanley Kramer che si chiamava "On the beach", "L'ultima spiaggia", per noi italiani. Ipotizzava una guerra nucleare nel 1964. Non è che fosse un'opera eccezionale, ma ha contribuito a radicare diversi immaginari: sul futuro post apocalittico, sulla precarietà dell'umanità nella guerra fredda e sull'idea di un mondo vuoto dagli uomini, come nell'emblematica sequenza dello sbarco a San Francisco.
Tutto questo ha anche suggerito a Neil Young, cantautore canadese, il titolo di uno dei suoi album più riusciti, che ora qui cito per l'iconica copertina: una spiaggia desolata con Young in piedi di spalle che guarda il mare e la coda di un missile conficcato di traverso nella sabbia, un ombrellone giallo aperto, qualche sedia a sdraio sparsa in giro. Gli elementi di questa desolazione sono tutti pezzi di qualcosa di plausibile, il missile sembra essere uno di quelli delle giostre che popolano i nostri litorali, innocuo, un giocattolone; di quegli ombrelloni tanti ne abbiamo visti, tutto ok. Ma permane un senso di surreale inquietudine, perché tutto sembra essere in qualche modo scombinato, anche di pochi gradi, ma di misura fuori posto. Sfogliavo le immagini di Federico e tra le tante ci sono queste Polaroid, dove si vedono degli ombrelloni, certi aperti e certi chiusi, non ci sono le persone e la spiaggia sembra abbandonata, sembra l'ultima. Per la natura dell'emulsione della Polaroid, tutto sembra galleggiare indefinito in un territorio della memoria che ci riporta a quegli anni spensierati da una parte, popolati da famiglie allegre sulla 600, chioschetti con i posacenere Cinzano e il juke box, padri o fidanzati che piantano ombrelloni colorati facendo territorio e le giostre, con i cavallini e i missili; e poi altri missili dall'altra, quelli veri, che incombevano sulle nostre più o meno consapevoli teste mentre tutto scorreva placido in quest'Italia vacanziera.
Ho pensato che se un immagine ha un forte potere evocativo, e mi sbatte a zonzo per la memoria e l'immaginazione, e mi fa venire in mente cose che mi fanno bene e forse anche un po' male, vuol dire che è un'immagine efficace, con una vitalità intrinseca. Evocativa, che è un qualità dell'arte. Questo ho pensato.